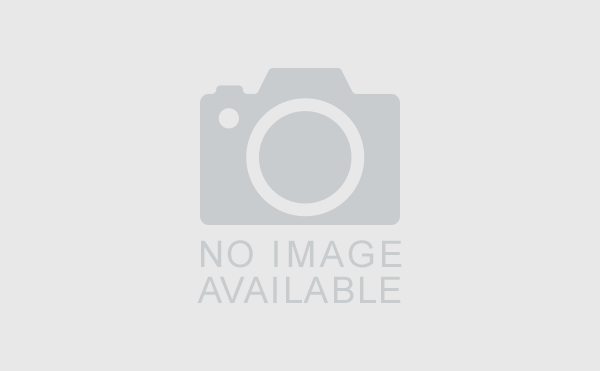𝐋𝐚 𝐩𝐢𝐥𝐥𝐨𝐥𝐚 𝐝𝐢 𝐝𝐢𝐫𝐢𝐭𝐭𝐨 𝐚𝐦𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝟏𝟖.𝟏𝟐.𝟐𝟎𝟐𝟒:L’Adunanza plenaria chiarisce i limiti dell’intervento nel processo amministrativo
L’Adunanza plenaria chiarisce i limiti dell’intervento nel processo amministrativo
a cura del cons. Luca Cestaro
#intervento #ad_adiuvandum #litisconsortile #cointeressato #adesivo-dipendente #ammissibilità #sospensione_impropria #processo_amministrativo #plenaria
Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 15 del 29 ottobre 2024
La vicenda alla base del giudizio
La controversia trae origine da due ricorsi presentati contro la deliberazione ARERA n. 580/2019/R/idr, con cui è stato approvato il metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio (MTI-3). Tale delibera disciplina il calcolo delle tariffe applicabili al servizio idrico integrato, stabilendo un meccanismo di differimento biennale per la corresponsione dei conguagli relativi ai costi sostenuti.
- Il caso Alfa: La società Alfa, partecipata per il 75% da privati e per il 25% dalla Regione Sicilia, operante come grossista dell’acqua per i gestori del servizio idrico integrato, ha contestato la legittimità del meccanismo tariffario. La società ha sostenuto che il differimento biennale per il riconoscimento dei costi tariffari avrebbe imposto agli operatori l’obbligo di anticipare risorse significative, senza il corrispondente riconoscimento di oneri finanziari, in violazione dei principi di full cost recovery ed equilibrio economico-finanziario sanciti dalla normativa europea e nazionale.
- Il caso Beta: Un ricorso parallelo è stato presentato da Beta S.p.A., un’altra società operante nel settore idrico, avverso la stessa delibera, con argomentazioni simili sul mancato riconoscimento di componenti tariffarie ritenute indispensabili per garantire la sostenibilità economica del servizio.
Entrambi i ricorsi sono stati inizialmente respinti dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, che ha ritenuto il meccanismo tariffario conforme ai principi di ragionevolezza e trasparenza, nonché compatibile con il parametro “beta” che considera i rischi imprenditoriali del settore.
La questione processuale dell’intervento
Nel giudizio dinanzi all’Adunanza Plenaria sono intervenuti diversi soggetti, ciascuno con una posizione specifica. In particolare, un’altra società impegnata nella gestione degli acquedotti nella Regione Puglia è intervenuta:
- Ad adiuvandum: in favore di Alfa, sostenendo che il differimento biennale dei conguagli crea effetti distorsivi sulle dinamiche economico-finanziarie degli operatori del settore.
- Ad opponendum: contro la tesi della società Beta per difendere la validità della delibera ARERA, ritenendola indispensabile per garantire la trasparenza e l’efficienza del sistema tariffario.
Questa pluralità di interventi, peraltro discordanti, ha sollevato il tema della ammissibilità dell’intervento e della correlazione tra l’interesse processuale e l’oggetto del giudizio.
L’intervento nel processo amministrativo
La Plenaria ricorda che l’intervento processuale svolge un ruolo cruciale nella teoria dell’azione, nella definizione dell’oggetto del giudizio e nei limiti soggettivi della tutela giurisdizionale. La sua funzione è quella di far emergere in sede processuale le diverse situazioni giuridiche soggettive, con tipologie e contenuti vari, che si trovano interconnesse nel contesto del diritto sostanziale. Ciò permette al giudice di comprendere appieno la complessità globale della controversia e di ampliare «lo spettro di estensione del giudicato».
Questo aspetto assume particolare rilievo nell’ambito dell’azione amministrativa, dove i provvedimenti solitamente incidono su una pluralità di interessi, sia pubblici che privati, e producono effetti che si estendono a situazioni ulteriori, dipendenti o connesse, rispetto a quelle relative alle parti necessarie del giudizio.
L’intervento è oggi regolato dall’art. 28 del c.p.a. («1. Se il giudizio non è stato promosso contro alcuna delle parti nei cui confronti la sentenza deve essere pronunciata, queste possono intervenirvi, senza pregiudizio del diritto di difesa. 2. Chiunque non sia parte del giudizio e non sia decaduto dall’esercizio delle relative azioni, ma vi abbia interesse, può intervenire accettando lo stato e il grado in cui il giudizio si trova. 3. Il giudice, anche su istanza di parte, quando ritiene opportuno che il processo si svolga nei confronti di un terzo, ne ordina l’intervento») e la stessa collocazione della norma rende evidente la derivazione della disciplina dal principio costituzionale del «contraddittorio tra le parti», quale componente del «giusto processo regolato dalla legge» (art. 111, secondo comma, Cost., richiamato dall’art. 2 del c.p.a.).
Peraltro, mentre nell’ambito della giurisdizione esclusiva in tema di diritti soggettivi valgono i principi elaborati nel processo civile, in quello della giurisdizione cd. di legittimità in tema di interessi legittimi valgono principi peculiari determinati dall’operatività del termine di decadenza per proporre impugnativa, collegato inscindibilmente al principio di certezza delle situazioni giuridiche di diritto pubblico.
Le tipologie di intervento nel processo amministrativo
La prima tipologia enucleata dalla Plenaria è quella dell’intervento adesivo-dipendente, effettuato in relazione a una situazione solo indirettamente collegata a quella incisa dal provvedimento. In tali casi, il carattere indiretto e mediato del pregiudizio subito esclude la legittimazione dei predetti soggetti a promuovere un autonomo giudizio (es. il potenziale subappaltatore rispetto al contratto di appalto nel giudizio condotto dall’appaltatore sull’esclusione dalla gara; acquirente di un immobile in relazione al ricorso già presentato dal precedente proprietario per il diniego di autorizzazione edilizia).
L’interventore, quindi, pur divenendo a tutti gli effetti parte del giudizio, deve limitarsi a cooperare con la parte adiuvata nell’attività asseverativa, senza potere introdurre domande, fatti o prove, o dare altrimenti impulso al giudizio.
La seconda tipologia è quella dell’intervento litisconsortile; in tal caso, l’interventore è titolare di un interesse direttamente inciso dal potere amministrativo e tale da radicare un autonomo potere di impugnazione. Il fondamento dell’intervento, in tal caso, non è quello di evitare la propagazione di un risultato processuale sfavorevole oppure di agevolare un esito processuale da cui ricavare in via derivata la soddisfazione del proprio interesse; piuttosto, la ratio dell’istituto è quella di favorire, per ragioni di economia processuale, il cumulo di impugnazioni (connesse per l’oggetto o per il titolo) in un unico processo, evitando la formazione di giudicati potenzialmente contraddittori.
L’interventore litisconsortile, ovviamente, ha il potere di ampliare l’oggetto del giudizio essendo titolare del potere di proporre autonomo ricorso e non essendo decaduto dalla possibilità di esercitarlo.
I limiti all’intervento litisconsortile
Già la pregressa giurisprudenza ha escluso il potere di intervenire in giudizio in capo a chi avrebbe potuto impugnare l’atto lesivo, prestandovi invece acquiescenza: si è ritenuto che ammettere in tal caso l’intervento (e consentire di avvalersi degli effetti dell’eventuale annullamento dell’atto lesivo) avrebbe comportato l’elusione del termine di decadenza. Si è ammessa, invece, la conversione dell’intervento in ricorso principale purché: non fossero (appunto) scaduti i termini di decadenza; fosse ravvisabile nell’interventore la volontà di agire quale ricorrente; l’atto di intervento possedesse i requisiti di sostanza e di forma del ricorso, compresi quelli di natura fiscale.
L’art. 28 del c.p.a., sopra citato, ha confermato che l’intervenuta decadenza impedisce l’intervento litisconsortile, mentre ovviamente analoga limitazione non sussiste per l’intervento adesivo dipendente che corrisponde a un interesse indiretto non tale da radicare né la legittimazione né, evidentemente, l’onere di impugnare nei termini decadenziali.
La medesima norma, peraltro, esclude che si debba operare la conversione dell’intervento in ricorso nella misura in cui prevede, come unica condizione, che l’interventore non sia scaduto dalla relativa azione.
La questione processuale controversa: ammissibilità dell’intervento adesivo dipendente in capo al potenziale litisconsorte
La Plenaria respinge la tesi che reputa possibile, per il potenziale litisconsorte (i.e.: portatore di un interesse diretto, cointeressato), pur decaduto dalla possibilità di impugnare, intervenire nei limiti dell’intervento adesivo-dipendente ossia senza poter ampliare in alcun modo l’oggetto del giudizio.
Questi gli argomenti a favore di tale (denegata) tesi:
- l’intervento ad adiuvandum è ammesso a chi subisce gli effetti indiretti (o riflessi) di una sentenza di annullamento; a maggior ragione, dovrebbe essere consentito a chi viene direttamente coinvolto dalla sua efficacia.
- La finalità dell’art. 28 del codice del processo amministrativo, che limita l’intervento a coloro che non abbiano lasciato scadere i termini per agire, non è quella di punire comportamenti inerti dei soggetti interessati, ma piuttosto quella di garantire stabilità e certezza ai rapporti giuridici e alle situazioni soggettive, evitando che l’azione amministrativa resti indefinitamente contestabile in sede giurisdizionale. Di conseguenza, una volta che uno dei destinatari abbia promosso validamente un giudizio sulla legittimità di un provvedimento amministrativo, non vi è più motivo di richiamare il termine di decadenza per impedire l’intervento di chi, pur senza ampliare l’oggetto della controversia, intenda semplicemente avvalersi del processo già avviato per sostenere le ragioni del ricorrente principale e ottenere, anche indirettamente, la tutela della propria posizione, considerata la natura inscindibile degli effetti del provvedimento.
In tale ottica, si afferma che l’intervento adesivo-dipendente è così definito non perché il portatore di tale intervento sia titolare di un interesse subordinato a quello del ricorrente principale, ma perché, tramite questa modalità, non è consentito ampliare l’oggetto del giudizio.
La Plenaria, come detto, respinge tale tesi per plurime ragioni.
In primo luogo, si valorizza «l’argomento di interpretazione letterale»: la possibilità dell’intervento adesivo-dipendente del cointeressato (litisconsorte) contrasta con la lettera dell’art. 28 co. 2 del c.p.a., che «pone espressamente quale condizione dell’intervento l’assenza del prodursi di una decadenza».
La disposizione citata, peraltro, richiede non solo che l’intervento del cointeressato sia proposto prima dello spirare del termine di decadenza, ma anche che «l’interventore “non sia decaduto dall’esercizio delle relative azioni”, il che postula che l’atto di intervento del cointeressato, oltre che tempestivo, contenga la domanda di annullamento». L’intervento del cointeressato, nell’impostazione del legislatore deve, quindi, avere carattere litisconsortile.
In secondo luogo, sul piano logico e strutturale, l’intervento adesivo-dipendente è incompatibile con la titolarità di un autonomo interesse all’impugnazione. Questo perché chi ha un interesse giuridico qualificato deve rispettare i termini di decadenza previsti per proporre ricorso. Una volta scaduti questi termini, il cointeressato perde ogni possibilità di far valere il proprio interesse in giudizio.
L’esattezza di tale conclusione risalta con evidenza nel caso di atti individuali o di atti plurimi con effetti scindibili (es. graduatoria di un concorso pubblico) in quanto il superamento del termine di decadenza comporta l’inoppugnabilità dell’atto, privando il soggetto decaduto di qualsiasi interesse, anche di fatto, a impugnare.
La medesima soluzione, peraltro, si impone anche in relazione agli atti con effetti inscindibili o con effetti generali (come nei casi di regolazione tariffaria); anche in tal caso prevalgono le esigenze di stabilità e certezza dell’azione amministrativa, che impediscono l’intervento del cointeressato decaduto.
In proposito, la Plenaria osserva che, di norma, il giudicato amministrativo opera solo tra le parti del giudizio, in conformità all’art. 2909 c.c., e non produce effetti verso i terzi estranei, né a loro vantaggio né a loro svantaggio.
Tuttavia, esistono eccezioni in cui il giudicato ha effetti ultra partes, ad esempio quando riguarda atti di natura inscindibile (come regolamenti o atti che disciplinano unitariamente più soggetti) o atti plurimi rispetto ai quali, tuttavia, viene censurato un vizio comune alla posizione di tutti i destinatari. In simili casi, peraltro, solo gli effetti di annullamento del giudicato operano erga omnes, mentre l’autorità del giudicato sul piano degli effetti conformativi (in particolare, quelli che impongono che la P.A. provveda nuovamente tenendo conto delle ragioni affermate dalla Sentenza) resta limitata alle parti del processo.
«Se si ammettesse l’intervento tardivo del cointeressato decaduto,» – conclude la Plenaria – «questi ‒ divenuto parte del giudizio ‒ potrebbe azionare gli effetti conformativi del giudicato di annullamento, essendo la sua posizione soggettiva ricompresa nel giudicato materiale. Ciò avverrebbe in evidente elusione dei termini decadenziali, in tutte le ipotesi in cui l’obbligo conformativo dell’Amministrazione di colmare “ora per allora” il vuoto regolatorio determinato dal giudicato, non deve necessariamente riguardare ‘indivisibilmente’ tutti i rapporti astrattamente regolati dall’atto generale annullato».
All’esito del ragionamento appena riassunto, l’Adunanza plenaria enuncia il seguente principio di diritto: «L’art. 28, comma 2, del codice del processo amministrativo va interpretato nel senso che – nel giudizio proposto da altri avverso un atto generale o ad effetti inscindibili per una pluralità di destinatari – è inammissibile l’intervento adesivo-dipendente del cointeressato che abbia prestato acquiescenza al provvedimento lesivo».
La possibilità dell’intervento cd. nomofilattico
L’Adunanza Plenaria richiama i propri precedenti in ordine alla possibilità di intervenire per chi, successivamente all’ordinanza di rimessione, intenda partecipare al processo solo per ottenere un precedente giurisprudenziale da utilizzare in un giudizio distinto e separato. Si rammenta che, a partire dalla sentenza n. 17 del 1971, tale tipologia di intervento è stata ritenuta inammissibile.
Dopo l’entrata in vigore dell’art. 99 del codice del processo amministrativo (c.p.a.), l’Adunanza Plenaria ha ribadito questa posizione con diverse sentenze (n. 23/2020, n. 4/2019, n. 13/2018, n. 23/2016), precisando che:
- Non basta l’esistenza di una questione giuridica analoga tra due giudizi distinti per giustificare l’intervento.
- Ammettere un intervento basato su una semplice analogia giuridica introdurrebbe un concetto di interesse privo di collegamento con l’oggetto specifico del processo, aprendo il rischio di azioni emulative.
Inoltre, con la sentenza n. 18/2021, è stata esclusa la possibilità di intervento da parte di soggetti (pubblici, privati o associazioni di categoria) interessati unicamente alla definizione di una regola giuridica applicabile a casi futuri.
La rilevanza giuridica dell’interesse al precedente nomofilattico (principio di diritto vincolante) non giustifica l’intervento, neanche invocando una violazione del diritto di difesa.
L’art. 99, comma 3, c.p.a. stabilisce che l’Adunanza Plenaria ha il compito di risolvere contrasti giurisprudenziali con decisioni vincolanti per le sezioni semplici, ma ciò non modifica il carattere soggettivo e di parti del giudizio amministrativo.
Il vincolo che deriva dalla decisione della Plenaria, peraltro, non equivale a uno “stare decisis” assoluto: le sezioni semplici che non condividano il principio possono rimettere nuovamente la questione alla Plenaria.
La conclusione appena raggiunta viene confermata anche qualora il giudice, T.A.R. o sezione semplice del C.d.S., abbia disposto la cd. sospensione impropria ‘in senso lato’ del processo per attendere il pronunciamento dell’Adunanza plenaria.
Neppure tale circostanza, infatti, introduce un vulnus al principio di difesa in relazione alla denegata facoltà di intervenire nel giudizio innanzi alla Plenaria.
Difatti, qualora il processo innanzi a una Sezione del Consiglio di Stato venga sospeso in attesa della risoluzione, in un diverso giudizio, di questioni come un incidente di costituzionalità, una pregiudiziale eurounitaria o una rimessione all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, si è chiarito (v. Ad. Plen. n. 4/2024) che l’ordinanza di sospensione può essere adottata solo previa attivazione del contraddittorio, come previsto dall’art. 73, comma 3, c.p.a. «e solo se le parti o almeno una di esse non chiedano di poter interloquire davanti la Corte costituzionale, la CGUE, la Plenaria, nel qual caso va disposta una nuova rimessione (con conseguente sospensione impropria “in senso stretto” nelle prime due ipotesi)»; nessuna violazione del diritto di difesa è, quindi, ipotizzabile.
Parimenti, nessuna violazione del diritto di difesa sussiste se la sospensione viene operata, in primo grado, dal T.A.R. e ciò perché:
- il T.A.R. non è obbligato a conformarsi al principio di diritto stabilito ai sensi dell’art. 99 c.p.a.;
- la parte soccombente ha la possibilità di proporre appello, avanzando argomentazioni volte a convincere la sezione del Consiglio di Stato a rivedere il principio di diritto considerato non corretto e a rimettere nuovamente la questione all’esame dell’Adunanza Plenaria.
Questo il principio di diritto affermato sulla questione: «qualora sia pendente innanzi all’Adunanza Plenaria un giudizio nel quale si faccia questione di profili di illegittimità di un atto generale regolatorio, avente effetti nei confronti di una intera categoria di operatori economici, è inammissibile l’intervento – innanzi alla medesima Adunanza Plenaria ‒ di chi abbia impugnato il medesimo atto con un ricorso ancora pendente innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale»
La conclusione
Nel caso concreto, gli interventi in giudizio, di senso diverso, effettuati dalla società che gestisce alcuni acquedotti nella Regione Puglia sono stati ritenuti entrambi inammissibili poiché, nel primo caso, si trattava di intervento litisconsortile (la società aveva la posizione di cointeressato) rispetto al quale era decorso il relativo termine di decadenza e, nel secondo caso, si trattava di un intervento ‘nomofilattico’.